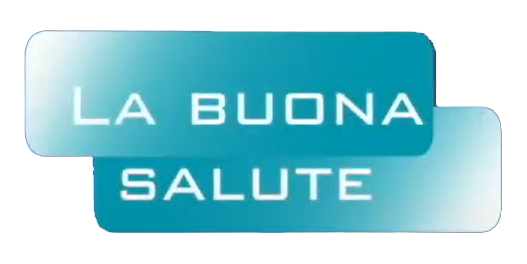Cari Lettori
ha suscitato stupore e turbamento lo studio effettuato recentemente da alcuni ricercatori dell’Imperial College di Londra volto a dimostrare la presenza di lesioni a livello del cervello in alcuni soggetti guariti da COVID-19, danni che – ipotizza lo studio – potrebbero addirittura portare a deficit cognitivi – quindi una sorta di demenza senile anticipata – in un numero non precisabile di pazienti.
Senza voler alimentare un inutile allarmismo, in quanto questi dati dovranno essere validati e confermati in studi successivi, voglio nella puntata odierna della nostra rubrica spiegare perché, da un punto di vista anatomico, l’ipotesi è fondata e merita pertanto di essere ulteriormente approfondita.
In uno dei nostri primi appuntamenti (https://www.sanitainsicilia.it/gocce-anatomia-coronavirus-banale-influenza-unaggressione-autoimmune_408057/) abbiamo spiegato cosa renda questo virus particolarmente insidioso, soprattutto in un sottogruppo della popolazione, definibile fragile, ossia soggetti affetti da ipertensione, diabete o – sic et simpliciter – senescenza, in quanto queste condizioni favoriscono l’insorgenza di cambiamenti “strutturali” a carico di proteine normalmente “nascoste” dentro le cellule che – a seguito di queste modifiche – possono essere esposte sulla superficie cellulare, potendo teoricamente diventare bersagli per l’immunità scatenata dal nostro organismo contro il virus.
Se ciò avviene nelle cellule endoteliali, il rischio è che si formino coaguli dentro i vasi, condizione di per sé grave ma che può diventare fatale se il soggetto ha già uno o più organi compromessi da altre patologie.
Il cervello è ricchissimo di vasi ed è “affamato” di ossigeno. Pur rappresentando circa il 2% del peso corporeo, il nostro cervello riceve oltre il 15% della gittata cardiaca e consuma circa il 20% dell’ossigeno captato a livello polmonare. Questo è ulteriormente testimoniato dalla ricca rete anastomotica di vasi presente alla base del cranio (il cosiddetto “circolo di Willis”) funzionale ad assicurare una distribuzione di sangue costante alle varie aree cerebrali, anche in condizioni di flusso ematico transitoriamente ridotto.
Tuttavia, alle volte questo può non bastare, soprattutto in alcuni distretti cerebrali nei quali – come è stato dimostrato da accurati studi scientifici – vi sono dei neuroni maggiormente sensibili alla carenza di ossigeno o ad altri fattori stressogeni.
Uno di questi distretti è l’ippocampo (o corno di Ammone), una regione anatomica cerebrale che ha incuriosito gli anatomisti di epoche lontane che lo hanno “battezzato” con questo termine per la sua somiglianza con il cavalluccio marino (o, rispettivamente, con la forma delle protuberanze frontali con le quali veniva frequentemente rappresentato la principale divinità dell’antico Egitto).
Si tratta di una piccola area di corteccia cerebrale che si “arrotola” all’interno della regione del nostro cervello corrispondente alle tempie, assottigliandosi, formata da tre raggruppamenti di neuroni (CA1, CA2 e CA3, dove CA ovviamente sta per “corno di Ammone”) studiatissimi in neuroscienze e dei quali praticamente si conoscono tutti i dettagli morfologici e molecolari.
Ad esempio, è risaputo che i neuroni appartenenti al gruppo CA1 sono particolarmente sensibili all’ipossia, ossia la riduzione della concentrazione di ossigeno nel sangue che, nei pazienti affetti da COVID-19, può verificarsi per almeno due ordini di fattori: la distruzione del parenchima polmonare (la cosiddetta, e ormai tristemente famosa, polmonite interstiziale bilaterale) e l’anemia emolitica autoimmune che – a nostro avviso – può essere ingenerata dagli stessi fenomeni autoimmuni precedentemente ricordati, stavolta a carico dei globuli rossi (come da noi evidenziato lo scorso mese di luglio in questa pubblicazione scientifica: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjh.16883).
Come se non bastasse, i neuroni appartenenti al gruppo CA3 sono inoltre particolarmente sensibili ai livelli elevati di cortisolo, l’ormone prodotto dal surrene, la cui concentrazione ematica si innalza in condizioni di stress (quali ad esempio quelle susseguenti a un ricovero in ospedale per una malattia potenzialmente mortale). A complicare ulteriormente il quadro bisogna ricordare che l’analogo sintetico del cortisolo è il cortisone, una molecola farmacologicamente attiva e che è diventata estremamente importante nella cura del COVID-19 in quanto uno dei pochi farmaci in grado di ridurre drasticamente la risposta iperimmune e autoimmune innescata dal virus contro il nostro organismo e quindi, potenzialmente, di salvare centinaia di migliaia di vite umane. Va da sé che somministrando elevate dosi di cortisone a un paziente a rischio di vita, se da un canto ci consente di salvarlo, dall’altro canto rischiamo di arrecargli danni irreversibili al suo ippocampo.
Ma perché questa piccola area del cervello è così importante tanto da doverci preoccupare di salvaguardarne l’integrità di ogni suo singolo neurone? Sintetizzare in poche righe decenni di studi e decine di migliaia di pubblicazioni sull’argomento, senza urtare la sensibilità dei colleghi neuroscienziati, è una missione impossibile. Mi limito a dire che l’ippocampo è coinvolto, tra gli altri, in due processi fisiologici: la formazione delle emozioni e il consolidamento delle memorie.
Per quanto riguarda le emozioni, l’ippocampo fa parte di quell’insieme di strutture nervose – che prendono il collettivamente il nome di “sistema limbico” – che sono responsabili dell’attribuzione di un significato emozionale alle esperienze sensoriali. Qualcosa su cui un giorno mi piacerà ritornare in un’altra puntata di questa rubrica. Per quanto riguarda le memorie, ovviamente il meccanismo è strettamente correlato al precedente: tutti quanti ricordiamo meglio le esperienze a cui il nostro cervello ha attribuito un più elevato significato emozionale, tralasciando di ricordare quelle emotivamente più scialbe.
Da ciò è derivato un grande interesse nei confronti dell’ippocampo da parte di tutti i neuroscienziati che si occupano di studiare le cause della demenza (che, per l’appunto, esordisce ed è caratterizzata da episodi di perdita di memoria), e infatti è risultato che l’ippocampo è una delle prime strutture anatomiche a risultare morfo-funzionalmente danneggiata già nelle fasi precoci di declino cerebrale.
Pertanto, riallacciandoci a quanto detto in premessa e avviandoci alle conclusioni, i soggetti ospedalizzati per le forme più gravi di COVID-19 e poi guariti hanno – ipoteticamente – un rischio più alto di aver subito un danneggiamento a livello cerebrale e, in particolare, ippocampale; questo – a cascata – potrebbe portare nel giro di alcuni anni, in un piccolo sottogruppo di essi, allo sviluppo di forme precoci di demenza. È un’ipotesi tutta da verificare, quella postulata dai colleghi inglesi, ma che merita rispetto perché assolutamente fondata su solide basi anatomiche.